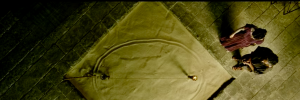Erano anni in cui la telefonia mobile andava a gonfie vele.
Il budget dell’anno si chiudeva già a marzo, e da lì in poi era tutto margine, tutto entusiasmo.
Gli operatori mobili erano i nuovi padroni della scena: compagnie aeree, società di viaggi, riviste e brand internazionali facevano la fila per entrare nel “piccolo schermo” dei telefoni.
Non si parlava più solo di voce o SMS, ma di contenuti, esperienze, emozioni in movimento.
Fu in quel fermento che Playboy Italia bussò alla porta, rappresentata dall’agenzia romana Lancio, una realtà abituata a muoversi tra editoria, spettacolo e glamour.
L’idea era chiara e provocatoria: trasportare il mondo di Playboy sui nuovi dispositivi mobili — portare l’immaginario più antico del mondo dentro la tecnologia più giovane del pianeta.
All’inizio lo prendemmo quasi come una sfida intellettuale.
Ma quando arrivarono i primi numeri, le prospettive di licenza e l’interesse del gruppo americano, capimmo che era qualcosa di più serio.
Il progetto divenne troppo interessante per restare locale.
Con Marina, responsabile del marketing, decidemmo di partire per Chicago, sede storica della Playboy Mansion e del quartier generale editoriale.
Ricordo ancora quella partenza come fosse un film.
Io — che non dicevo mai di no a un biglietto intercontinentale — ero pronto con la mia valigetta piena di schemi e presentazioni; lei, con l’eleganza e l’ambizione che la contraddistinguevano, tentò la tratta con il Concorde da Parigi.
Un volo di poche ore, supersonico come il nostro entusiasmo.
Ma non trovò posto.
Alla fine ci ritrovammo a New York, come in una scena di A Colazione da Tiffany, e da lì volammo insieme verso Chicago.
Era il 2001, e l’aria sapeva di futuro: la bolla Internet non era ancora esplosa del tutto, le aziende si contendevano partnership tecnologiche, e ogni progetto sembrava possibile.
Nelle radio d’aeroporto suonavano “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue e “Drops of Jupiter” dei Train— melodie leggere ma già intrise di quella nostalgia digitale che stava per arrivare.
Atterrammo a O’Hare, nel cuore dell’Illinois, in una mattina di vento tagliente.
Appena usciti dal terminal, la prima cosa che mi colpì fu il silenzio digitale.
I tassisti non avevano telefoni cellulari — in quegli anni, nel Midwest, il GSM non era ancora arrivato — ma ognuno di loro stringeva in mano un walkie-talkie, grande e rumoroso, collegato alla centrale via onde radio.
Ogni chiamata era un gracchiare metallico, un linguaggio spezzato di codici e nomi, come in una base spaziale o in un film poliziesco degli anni ’70.
Era curioso: in Europa ormai ci scrivevamo SMS e navigavamo via WAP, ma lì, a migliaia di chilometri, la comunicazione era ancora analogica, fisica, rumorosa.
Un piccolo promemoria che la rivoluzione digitale non avanza mai alla stessa velocità ovunque.
E quella contraddizione — la tecnologia più avanzata al servizio del contenuto più antico del mondo, e intorno un’America che comunicava ancora via walkie-talkie — dava al nostro viaggio un tono surreale.
Mentre salivamo sul taxi, Marina mi guardò e disse:
«Altro che roaming internazionale, qui siamo tornati ai tempi di Colombo.»
Sorrisi. In fondo, anche noi eravamo lì per esplorare un continente nuovo: quello del desiderio digitale.
Il nostro obiettivo era spiegare, davanti a un gruppo di manager americani in giacca chiara e sorriso calibrato, come veicolare il contenuto più vecchio del mondo sui nuovi dispositivi mobili.
Non si trattava di pornografia — si trattava di immaginario, di estetica, di storytelling.
La domanda chiave era semplice e potentissima:
“Come tradurre il fascino e l’erotismo in un linguaggio compatibile con la rete mobile?”
A Chicago scoprimmo che Playboy stava già sperimentando contenuti interattivi, micro-animazioni e formati video compressi.
E noi, venuti dall’Europa, con il nostro background tecnico e la leggerezza mediterranea, avevamo una marcia in più.
Capivamo la tecnologia e la narrazione.
Eravamo i pontieri tra due mondi.
Il meeting nella sede centrale — tra pannelli in legno, fotografie storiche e un logo che brillava al neon rosa — aveva il sapore delle grandi occasioni.
E mentre Marina spiegava il piano di marketing globale, io presentavo le prime demo WAP e Flash che avevamo preparato per mostrare come una rivista potesse vivere in un telefono.
Era ancora l’epoca dei Nokia 7110 e dei Siemens S45, con schermi monocromatici, ma le idee correvano più veloci dei processori.
Ricordo l’effetto negli occhi dei manager americani: un misto di stupore e incredulità.
La nostra proposta era qualcosa di inedito — portare un’icona culturale dentro un dispositivo personale.
Era il punto d’incontro tra desiderio e tecnologia, intimità e mobilità.
Chicago ci accolse con il vento freddo del lago Michigan e l’odore dei diner americani.
Una sera, dopo le riunioni, ci trovammo in un jazz club, e sul palco un trio suonava “The Girl from Ipanema” in versione elettronica.
Pensai che in fondo, in quella musica e in quella città, c’era già tutto: ritmo, sensualità, connessione.
Era proprio lì che la tecnologia stava imparando a parlare la lingua del fascino.