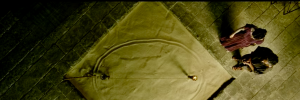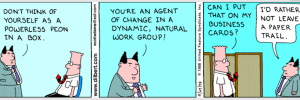Quando nel 1999 lasciai Sun Microsystems, il mondo stava cambiando pelle. Dopo un decennio trascorso tra server, reti e linguaggi distribuiti, la parola chiave era diventata mobilità.
Internet stava uscendo dai laboratori per entrare nelle tasche: la telefonia mobile digitale stava incontrando la rete.
Già qualche anno prima avevo intuito che da Nord si stava muovendo qualcosa.
Durante alcuni viaggi in Finlandia, terra di laghi, silenzi e luce rarefatta, avevo percepito che lì si stava scrivendo il futuro.
Nel 1991, proprio in Finlandia, era nata la prima rete GSM al mondo — una rivoluzione silenziosa che avrebbe trasformato per sempre la comunicazione.
Negli anni seguenti, tra Oulu e Rovaniemi, frequentai gruppi di ricerca universitari che lavoravano su progetti legati alla connettività e all’interazione uomo–macchina.
Fu lì, in un inverno che sembrava non finire mai, che nacque TelephoNet, un progetto europeo concepito negli ultimi mesi in Sun Microsystems, con l’obiettivo di unire Gemalto, Nokia e il mondo nascente di Internet.
L’università di Oulu offrì il primo supporto economico, mentre a Rovaniemi, in un campus circondato dalla neve e dal silenzio, trovammo le competenze per il design e la prototipazione.
Fu il mio primo contatto diretto con l’universo delle Human–Computer Interfaces, quando ancora in Europa la parola “usabilità” non era di moda.
In quel periodo creammo un contenitore di idee internazionali, dove ai ricercatori finlandesi si unirono università giapponesi come quella di Kyoto, portando una sensibilità estetica e filosofica diversa, più attenta all’armonia tra gesto e funzione.
L’Italia restava un riferimento mondiale nel design industriale, ma stava avvenendo un passaggio epocale: dal design degli oggetti fisici al design delle interfacce, dove la materia era ormai fatta di pixel, luce e movimento.
Era un periodo di entusiasmo contagioso.
In radio passavano “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, “Smooth” di Santana e Rob Thomas, e “Bitter Sweet Symphony” dei Verve.
Erano canzoni che raccontavano perfettamente quella stagione sospesa tra ottimismo tecnologico e malinconia analogica.
Fu in questo clima che, grazie a Giovanni, un mio compagno di corso AUC, arrivò la proposta di unirmi a Omnitel 2000.
Un progetto ambizioso, quasi poetico nella sua visione: portare Internet dentro la telefonia mobile, trasformando il telefono in una piattaforma personale di servizi.
La prima riunione, in un pub di via Messina a Milano, sotto la guida di Vincenzo Novari, aveva il sapore delle cose nuove.
Attorno al tavolo, tra birre e block notes, un gruppo eterogeneo: alcuni provenivano da Italtel, altri dal mondo del software e delle reti, altri ancora — come me — da esperienze internazionali.
Il nome in codice era Venus: un progetto nato per avvicinare due mondi che fino ad allora si ignoravano, la telefonia e Internet.
Molti colleghi provenivano dalla divisione PAVA, acronimo italiano per Servizi a Valore Aggiunto (VAS).
Prima dell’arrivo di Internet, i “valori aggiunti” erano semplici: segreterie telefoniche, SMS informativi, poco altro.
Ora, invece, si parlava di speech recognition, WAP, portali mobili.
Uno dei primi telefoni su cui sperimentammo fu l’Alcatel One Touch Easy, un nome che in inglese suonava bene ma che durante la presentazione a Napoli fece sorridere più d’un collega perchè veniva oercepita come : “t’accis !”.
Era la perfetta metafora di quell’epoca: la tecnologia cominciava a diventare popolare, vicina, persino ironica.
In quei mesi chiamai Maurizio, Antonella e Monica per creare una piccola task force.
Maurizio veniva dalla consulenza, pragmatico e analitico;
Antonella, dalle strategie di Italtel, portava rigore e visione;
Monica, esperta di pagamenti bancari, un mondo di carte PVC e terminali POS.
Il concetto di secure element o di Apple Pay sarebbe arrivato anni dopo — e oggi fa sorridere, se si pensa a quanta ingegneria ci serviva allora per processare un semplice pagamento.
Fu da quella squadra che nacque Omnipay, il primo progetto di e-commerce sviluppato da un operatore mobile, dove billing e rete GSM si fondevano con i primi tentativi di transazione digitale.
Ma non ci fermammo lì.
In parallelo, realizzammo anche Omnishop, il primo portale interamente sviluppato in Flash, quando ancora Macromedia — non ancora acquisita da Adobe — rappresentava la frontiera più creativa del web.
L’idea di un portale dinamico, fluido, con animazioni vettoriali e interattività grafica, era rivoluzionaria.
Lavoravamo di notte su timeline e keyframe, tra script ActionScript 1.0 e sfondi verdi Omnitel, convinti che l’animazione fosse la nuova forma del linguaggio visivo.
Quando anni dopo Adobe comprò Macromedia e Flash iniziò la sua lenta dismissione, molti di noi sentirono di aver assistito alla fine di un’epoca — quella del web come laboratorio d’arte e codice insieme.
Intanto, nei reparti marketing, si moltiplicavano idee e progetti: ringtones, wallpapers, WAP portals.
Erano i primi walled garden, spazi chiusi ma curati, dove il verde Omnitel contrastava il rosso TIM anche nella filosofia: libertà contro rigidità, esplorazione contro conservazione.
Alla fine del 2000, mentre il mondo archiviava la paura del Millennium Bug e Internet correva verso la bolla speculativa, a Milano si respirava energia pura.
Con il progetto Venus, avevamo attraversato una soglia: dal mondo dei server Sun a quello delle reti mobili, dalle macchine che dialogavano tra loro alle persone che cominciavano a farlo attraverso uno schermo.
In sottofondo, in radio, passava “Beautiful Day” degli U2, quasi un inno a quel momento di passaggio.
E in quel verde Omnitel, acceso e vitale, c’era tutta la promessa di un futuro connesso e umano, dove il design non serviva più solo a costruire oggetti, ma a dare forma alle esperienze.
Un filo partiva dai laboratori di Oulu e Kyoto, attraversava via Messina e arrivava fino ai nostri telefoni colorati.
Un filo che oggi chiamiamo vita digitale — ma allora era solo una straordinaria avventura.