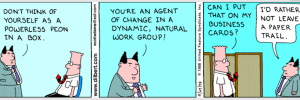Il 1997 fu un anno in bilico tra due mondi.
Non era più il secolo delle macchine e dei cavi sottomarini, ma non era ancora quello delle reti invisibili e dei satelliti che illuminano il cielo notturno.
Era un tempo di passaggio, di confine, in cui la Terra cominciava davvero a parlare con se stessa.
Internet, che fino a poco prima era un esperimento per università e ricercatori, entrava nelle case con i primi modem rumorosi e le connessioni lente.
Quel suono metallico — il fruscio di un handshake, l’attesa di una linea che rispondeva da lontano — divenne la voce di una nuova era.
Era l’anno in cui Hotmail regalava a milioni di persone la prima e-mail, in cui Yahoo! e Netscape disegnavano le mappe del web, e in cui Microsoft lanciava Internet Explorer 4 per conquistare il mondo.
Non esisteva ancora Google, ma si cominciava a intuire che la conoscenza stava cambiando forma.
Nel frattempo, il mondo intero seguiva la sfida tra Garry Kasparov e Deep Blue, il supercomputer di IBM che riuscì a battere l’uomo nel gioco più simbolico di tutti: gli scacchi.
Fu un evento che andò oltre la tecnologia — era il segnale che le macchine stavano imparando a pensare, o almeno a calcolare più velocemente di noi.
L’economia correva spinta dall’euforia della new economy.
Negli Stati Uniti Bill Clinton parlava di prosperità digitale, in Europa Romano Prodi e i leader dell’Unione lavoravano alla nascita dell’euro, mentre dall’altra parte del mondo una crisi improvvisa, quella del Sud-Est asiatico, mostrava le prime crepe del sistema globale.
Il 1º luglio, Hong Kong tornava alla Cina dopo 156 anni di dominio britannico — un passaggio che sembrò segnare la fine di un secolo e l’inizio di un altro.
E il 31 agosto, la morte tragica di Lady Diana a Parigi unì il pianeta in un lutto collettivo, uno dei primi trasmessi in tempo reale, come un’unica voce planetaria.
Anche lo spazio si fece più vicino.
Il Mars Pathfinder atterrò su Marte e il piccolo rover Sojourner cominciò a muoversi lentamente sulla superficie del pianeta rosso, inviando immagini che percorrevano l’etere e la Rete fino ai computer di mezzo mondo.
Era la prima volta che l’umanità poteva vedere un altro mondo attraverso uno schermo.
E intanto la musica cambiava tono.
Nelle radio europee suonavano Bitter Sweet Symphony dei Verve, Around the World dei Daft Punk, e OK Computer dei Radiohead dava voce all’inquietudine tecnologica di una generazione che cominciava a sentirsi connessa, ma anche osservata.
Era un’epoca di colori brillanti, monitor a tubo catodico, loghi 3D e speranze lucide come le superfici dei nuovi computer.
Il 1997 fu un anno di sogni e contraddizioni.
La globalizzazione sembrava una promessa di progresso e libertà, ma già si intravedevano le ombre dell’omologazione e della disuguaglianza.
La tecnologia era vista come una forza redentrice, eppure molti iniziavano a chiedersi se non ci stessimo spingendo troppo oltre, troppo in fretta.
E fu proprio in quell’atmosfera sospesa, carica di fiducia e vertigine, che prese forma uno dei progetti più visionari del tempo: Iridium, la rete satellitare di Motorola che prometteva di connettere ogni angolo del pianeta.
Un sogno di cavi invisibili che attraversavano il cielo invece degli oceani, un ponte di 66 satelliti che univa deserti, oceani e città.
Per me, il 1997 non fu solo un anno di grandi titoli sui giornali o di nuove canzoni in radio.
Fu l’anno in cui mi ritrovai anch’io a lavorare sotto quel cielo, tra la sabbia rossa dell’Arizona e le parabole del Fucino, con le macchine Sun che ronzavano come strumenti di un’orchestra orbitale.
Un progetto a metà tra Italia e America, tra il sogno e la fatica, tra il cavo e il cielo.
Nel 1997 il mondo guardava verso il cielo. Io, invece, ci arrivai dal basso — da un volo per Phoenix che atterrava nel cuore di un deserto chiamato Mesa…