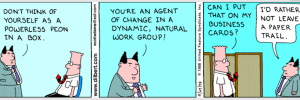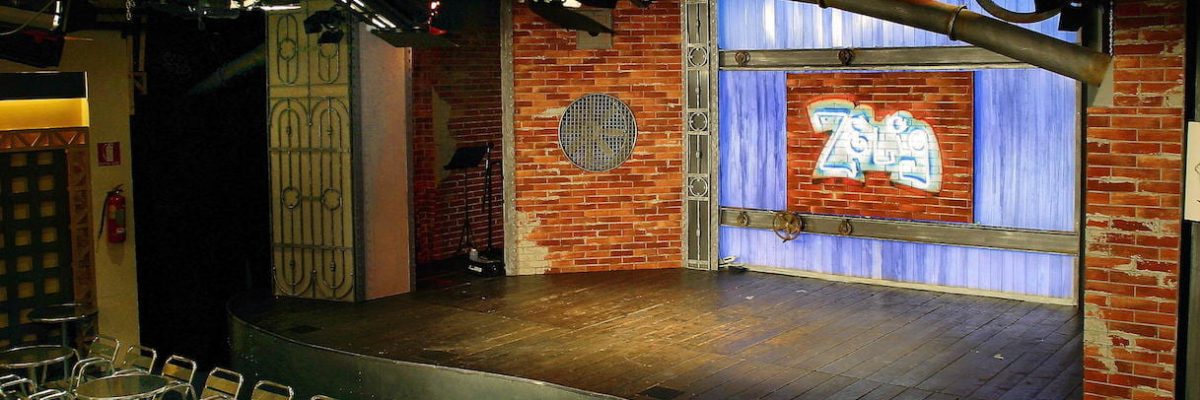
C’era un momento, a metà degli anni Novanta, in cui tutto sembrava possibile.
Il mondo correva verso Internet, i computer diventavano più piccoli e potenti, e nelle aziende si respirava un’aria elettrica, densa di entusiasmo e promesse.
Io arrivavo da un lungo periodo di Ricerca & Sviluppo, ma quel mondo stava cambiando.
Le stanze dei laboratori si svuotavano, mentre nascevano i servizi professionali, i reparti di consulenza e di supporto tecnico. Non contava più solo saper programmare e configurare: bisognava saper tradurre la tecnologia in valore umano.
Fu così che approdai, per un breve ma intenso periodo, alla MCS – Microsoft Consulting Services. Un’offerta irrinunciabile che mi fece capire che il futuro non apparteneva solo a chi sapeva scrivere codice, ma a chi sapeva comunicare, collegare, costruire relazioni.
Ma purtroppo per Mauro ed Ezio, quanche settimana dopo aver accettato l’offerta, arrivò quella di Sun Microsystems, e con lei una rivoluzione.
Sun non era semplicemente un’azienda: era una filosofia di vita. “The Network is the Computer” era più di uno slogan, era un manifesto.
Le giornate scorrevano tra workstation SPARC, terminali X11, e discussioni infinite su Solaris, TCP/IP, NFS e il futuro degli Open Systems.
In Italia, le grandi americane come HP, Apollo, SGI e la stessa Sun si erano insediate con proprie filiali, portando non solo prodotti ma cultura: un nuovo modo di lavorare, i casual friday, più orizzontale, cooperativo, internazionale.
Ogni New Hire era un rito.
Venivi mandato in California, tra Mounain View e Menlo Park (ora sede di Meta), per qualche settimana.
Lì imparavi il mestiere e respiravi un’aria diversa: quella delle startup, dei caffè a Palo Alto, delle biciclette davanti ai garage che avevano fatto la storia.
Le giornate erano piene di training, ma la sera cominciava la parte vera: partite di basket improvvisate sotto i fari delle auto, risate, racconti di progetti falliti e sogni futuri.
E poi, verso l’oceano. Una six-pack di Bud o di Corona, il profumo di salsedine e la musica che usciva gracchiante da una radio: la chitarra dei Counting Crows, Alanis Morissette, REM, Oasis.
Erano anni in cui ogni canzone sembrava parlare di noi.
Il 1996 fu un anno speciale.
Al Moscone Center di San Francisco, durante il SunWorld, James Gosling e il suo team presentarono un linguaggio che avrebbe cambiato tutto: Java.
Il motto era semplice e visionario: “Write once, run anywhere.”
L’idea che il software potesse essere indipendente dall’hardware, libero dai confini dei sistemi operativi, era pura poesia per chi, come noi, sognava un mondo connesso.
Da quell’evento nacque la JavaOne Conference, la prima nel 1996, proprio lì a San Francisco.
Durava quattro giorni – da lunedì a giovedì – e radunava migliaia di sviluppatori, ingegneri, architetti software.
Le sale del Moscone Center erano gremite: sessioni tecniche, Birds of a Feather (BOF) dove si discuteva fino a notte di nuovi framework, librerie, JVM, bytecode, sicurezza.
Nel 1999 arrivarono 20.000 partecipanti: una Woodstock per programmatori, un carnevale di idee e camicie hawaiane, dove il linguaggio Java era più di una tecnologia – era una tribù globale.
Io stesso, tra una demo e un coffee break, ricordo di aver pensato che quella non era solo una conferenza, ma un movimento culturale.
Ogni inizio di Fiscal Year in Sun era un altro rito collettivo.
Si festeggiava nei campus, nei teatri, o in sale piene di luci e musica.
C’era chi suonava chitarra, chi improvvisava discorsi, chi ballava sulle note di Bon Jovi o Bryan Adams.
La gerarchia spariva: tecnici, manager, segretarie, tutti sullo stesso piano, uniti da una sensazione inebriante — essere parte di qualcosa in crescita continua, sempre in ascesa.
Tornato in Italia, quell’energia cercava nuovi spazi.
A Segrate, la sera si giocava a calcetto, si parlava di progetti, di Solaris, di Java Virtual Machine, di clienti e nuove sfide.
Ma c’era anche un’altra parte di me che aveva bisogno di libertà, di un diverso tipo di palco.
Fu così che con Guido, Nadia, Rosa e altri amici iniziammo il nostro corso di improvvisazione teatrale, che trovò casa allo Zelig di viale Monza.
Era un’altra forma di rete: fatta non di cavi ma di emozioni.
Le prove erano caotiche e liberatorie – spesso finivano in risate, o in una ciabatta che volava dal pubblico verso il palco. Nei locali dei Navigli si incontravano Paolo Rossi, Antonio Albanese, Claudio Bisio: tutti stavano cercando, come noi, un linguaggio nuovo per raccontare un’Italia che cambiava. Quando nacque “Su la testa!”, lo spettacolo di Baggio, capii che anche il teatro, come la rete, serviva a connettere le persone, a dare voce a chi non ne aveva.
Tra un kernel Solaris e una scenetta improvvisata, tra una presentazione JavaOne e una birra ai Navigli, imparai che la creatività è la stessa energia, declinata in linguaggi diversi.
Scrivere codice, interagire con clienti, parlare in una conferenza o recitare senza copione: diversi modi per domare il caos, per creare connessioni, per far accadere qualcosa di vivo.
E se la California mi aveva insegnato a guardare in modo globale, Milano mi aveva ricordato come restare umano. Le due si completavano, come due estremi dello stesso circuito: uno fatto di bit, l’altro di battiti.