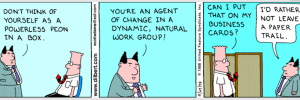Negli anni Cinquanta, Pisa era un luogo di convergenza fra scienza e filosofia, dove si avvertiva l’eredità del pensiero galileiano e la libertà accademica della Scuola Normale e dell’Università.
Fu qui che Enrico Fermi, interpellato nel 1954 sullo sviluppo scientifico della Toscana, suggerì di realizzare una Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP), una macchina destinata ad applicazioni tecnico-scientifiche.
In quel progetto Adriano Olivetti vide più di un’occasione tecnologica: colse la possibilità di portare la cultura umanistica italiana dentro la modernità elettronica.
Adriano non era un industriale come gli altri: credeva che il progresso non potesse nascere soltanto nelle fabbriche, ma nei luoghi in cui scienza, arte e comunità si incontrano. Per questo, nel 1955, decise di finanziare la collaborazione con l’Università di Pisa, offrendo risorse, competenze e strumenti. L’obiettivo non era solo costruire un calcolatore, ma creare un ecosistema di ricerca, un ponte tra industria e accademia, tra Ivrea e la Toscana, tra ingegneri e filosofi. Era convinto che l’informatica nascente avrebbe trasformato la società quanto la stampa o l’elettricità — e voleva che quella trasformazione avesse un’anima italiana.
Da questa visione nacque il Laboratorio di Ricerche Elettroniche (LRE) di Barbaricina, affidato al giovane ingegnere Mario Tchou. Un gruppo di ragazzi, quasi tutti neolaureati o diplomati, iniziò a costruire l’impossibile: un elaboratore elettronico competitivo con quelli americani. Nel giro di pochi anni, da quel laboratorio scaturì l’ELEA 9003, il primo computer interamente a transistor del mondo progettato e realizzato in Italia. Non solo un primato tecnico, ma un’opera culturale: Ettore Sottsass ne disegnò le forme eleganti, mentre Tchou e i suoi ricercatori ne perfezionarono l’architettura logica — un equilibrio raro tra estetica, ingegneria e pensiero sistemico.
Per Adriano Olivetti, Pisa fu la culla naturale di quel progetto: non una fabbrica, ma una bottega del pensiero, un laboratorio aperto dove la matematica si faceva poesia e la macchina diventava strumento di civiltà. Senza Pisa, senza quella scintilla toscana fatta di ricerca e libertà, Olivetti non avrebbe trovato la sua vocazione elettronica. La convinzione era chiara: l’Italia poteva competere nel mondo non solo con le macchine, ma con le idee.
Quando arrivai a Pregnana Milanese, era gennaio del 1990. Un anno-soglia per la comunità internazionale e, in Italia, l’estate delle notti magiche di Bennato e Nannini. Mentre il Paese cantava, nel cuore industriale e tecnologico — tra Olivetti, Bull, IBM, Italtel, SGS-Thomson — si parlava di reti, calcolo distribuito e workstation. Io, però, sottolineo tre eventi che stavano ridisegnando lo sfondo del nostro lavoro quotidiano:
- Fine della Guerra Fredda.Nel novembre ’89 era caduto il Muro di Berlino; nel 1990 la Germania si riunificò e i Paesi dell’Est intrapresero la transizione verso democrazia ed economia di mercato. In URSS Gorbaciov parlava di Perestrojka e Glasnost: il sistema stava collassando.
- L’Europa che cambia volto.A Roma, nel dicembre 1990, si firmarono gli accordi che portarono al Trattato di Maastricht: l’idea di una moneta comune e di un continente connesso non solo da strade, ma da reti digitali e commerciali.
- La nascita del mondo connesso.Al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee mise a punto il World Wide Web. Pochi se ne accorsero allora, ma aprire HTTP e HTML a tutti fu l’atto di nascita del web che conosciamo. Nello stesso periodo Linus Torvalds studiava i sistemi UNIX da cui sarebbe nato Linux. Qualche anno più tardi, nel ’96, lo avrei invitato con la fidanzata alla conferenza i2u a Milano.
L’eredità di Olivetti aleggiava ancora in ogni corridoio.
Anche se sulla facciata di Pregnana campeggiava ormai il logo Bull, si percepiva che quel luogo era nato da un’idea diversa: la visione di Adriano Olivetti, che negli anni Cinquanta aveva intuito il potenziale dell’elettronica e cercato alleanze per portare in Italia una cultura industriale umanistica, capace di unire impresa e conoscenza.
Già nel 1949, Adriano aveva stretto un accordo con la Compagnie des Machines Bull, l’azienda francese specializzata in macchine a schede perforate.
Era un’intesa lungimirante: Olivetti voleva ampliare lo sguardo oltre Ivrea, mentre Bull offriva un know-how tecnico sul calcolo automatico che in Italia ancora non esisteva.
Da quell’intesa nacque una joint venture tecnologica che portò i primi sistemi Bull nel nostro Paese e permise ai tecnici italiani di crescere fra Ivrea, Pisa e Milano.
Negli anni Ottanta, quella alleanza si rinnovò: Olivetti e Bull si ritrovarono fianco a fianco per affrontare l’avanzata americana di IBM, DEC e dei colossi emergenti del software.
Ma fu anche il tempo in cui Olivetti mise piede a Cupertino, nel cuore della Silicon Valley, con il progetto MultiCos, un sistema multiprocessore RISC concepito per anticipare la rivoluzione delle workstation.
L’idea era audace: combinare la tradizione ingegneristica europea con la visione californiana del calcolo distribuito.
Il MultiCos, sviluppato dal centro Olivetti Advanced Technology (OAT), rappresentava la risposta italiana al sogno del supercomputer “da scrivania” — anticipando, per certi aspetti, ciò che Sun Microsystems avrebbe poi consolidato con le sue SPARCstation e Silicon Graphics (SGI) avrebbe portato al massimo con le Indigo e le “pizza box”, le prime workstation grafiche leggere ma potentissime.
Quelle macchine, nate a pochi chilometri da Stanford, trasformarono il modo di progettare e visualizzare dati, ma l’idea — quella di un calcolo distribuito, cooperativo, e a misura d’uomo — era la stessa che aveva animato Ivrea.
Da Cupertino a Pregnana, passando per Grenoble e Ivrea, si respirava lo stesso spirito: unire la ricerca alla vita reale, rendere l’informatica strumento di libertà creativa.
La musica accompagnava il ritmo delle trasferte. Nel traffico della Milano-Torino, la radio passava “Losing My Religion”(R.E.M.) e “Enjoy the Silence” (Depeche Mode); sulle autostrade del Nord, “Wind of Change” (Scorpions) sembrava davvero annunciare un cambiamento nell’aria. Nel walkman gracchiavano “Alive” (Pearl Jam) e “Friday I’m in Love”(The Cure), mentre nei bar aziendali si parlava di client-server, di nuove reti TCP/IP e dei prototipi di workstation grafiche. Il calcolo diventava personale, ma la memoria collettiva restava industriale.
Nel mio ufficio di Pregnana eravamo in tre: io, Fabio e Stefano.
Fabio era mio coetaneo: rigoroso, concreto, con lo sguardo lungo dell’imprenditore.
Stefano era più giovane: curioso, veloce, con un talento naturale per le reti e l’integrazione software.
Nei primi mesi del 1990 non ci incontrammo quasi mai: eravamo tutti impegnati a erogare corsi su UNIX, X11 e Sistemi Aperti. Fabio era stabilmente a Canberra (Australia), Stefano in California, presso l’Università di San Diego. Io, invece, venni sparato per tre lunghi mesi nel Lancashire, a Lytham St Annes, nel dipartimento del DSS (Dept of Social Security) britannico, per gareggiare contro IBM, ICL e altri fornitori: una grande fornitura gestita insieme ai colleghi di Londra (Hounslow).
Il mio ruolo era quello che oggi chiameremmo interfaccia (allora dicevo antenna) fra i laboratori di Ricerca & Sviluppo: spiegare ai team di Pregnana ed Echirolles (Grenoble) le prove previste per le settimane successive, ricompilare di notte e spedire una versione di BOS-UNIX più performante, tarata sul “circuito” del giorno dopo. Come in Formula 1: la stessa vettura, ma assetto diverso a seconda del tracciato. Mi scelsero, certo, per l’inglese — allora ancora accademico, ma raro — e soprattutto per la capacità di tenere insieme profondità di sistema e networking con un po’ di empatia. Con gli inglesi di allora, molto più “british” di oggi, contava.
Il Lancashire era un tempo sospeso: il pub, il bingo, il tè bollente. Ricordo un referente che mi chiese di essere in ufficio all’alba: “dobbiamo andare da un cliente non vicinissimo”. Alle 6 del mattino imboccammo M1 e M6: capii perché. A Lytham, se chiedevi acqua al ristorante, arrivava calda; se chiedevi olio, portavano quello della Singer, la macchina da cucire. Un’Inghilterra più inglese di adesso.
Negli anni seguenti, le nostre strade professionali presero direzioni diverse. Fabio e Stefano scelsero la carriera imprenditoriale: prima in Open Network Enterprise, poi si sarebbero incrociati in ONE-ANS, contribuendo alla crescita dei servizi di rete in Italia. Io, invece, decisi di restare in una multinazionale: era la via che mi permetteva di continuare a conoscere ambienti diversi in Europa e Nord America, osservando da vicino come la tecnologia trasformasse organizzazioni e culture. Tre traiettorie differenti, ma figlie dello stesso luogo di partenza: Pregnana come crocevia di idee e persone.
Pregnana e Ivrea restano, per me, i due estremi dello stesso racconto:
Pregnana, laboratorio aperto sull’Europa, dove si sperimentava, si sbagliava, si migliorava;
Ivrea, culla dell’umanesimo industriale, dove ogni discussione tecnica conteneva un frammento di filosofia sociale.
Fra questi poli mi sono mosso come viaggiatore di confine — testimone di un’alleanza che ha segnato la storia e che, nonostante le trasformazioni aziendali, custodiva un nucleo ideale: la tecnologia al servizio dell’uomo. Era un’epoca in cui anche il silicio aveva un’anima, e Pregnana, con le sue architetture sobrie e il vento della pianura, era uno dei pochi luoghi in cui si poteva ancora sentirla.