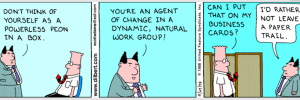L’estate del 1982 fu una delle più calde che io ricordi, e non solo per la temperatura. L’aria era densa, i ventilatori gracchiavano inutilmente nelle stanze, e mentre tutti sognavano il mare, io passavo le giornate chino sui libri. Avevo appena finito la maturità, a fine luglio, e invece di festeggiare o prendere fiato, mi buttai immediatamente nello studio: volevo entrare alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Al jukebox giravano brani che sarebbero diventati eterni. “Eye of the Tiger” dei Survivor rimbombava dalle radio locali, “Don’t You Want Me” degli Human League era ovunque, “Come On Eileen” dei Dexys Midnight Runners faceva ballare anche chi non voleva. “Africa” dei Toto cominciava a farsi largo, e “Promised You a Miracle” dei Simple Minds era la colonna sonora dei miei pomeriggi di studio. Ogni volta che entravo in un bar, in una sala giochi o in un circolo, quei pezzi scandivano il tempo.
E poi c’erano gli eroi del Mondiale. In Spagna, l’Italia stava compiendo un’impresa leggendaria: con Paolo Rossi in testa, trascinando la squadra con gol decisivi, e Dino Zoff al comando della difesa, diventato il capitano più anziano a vincere una Coppa del Mondo.
Marco Tardelli, con il suo urlo, che ancora oggi rimane una delle immagini indelebili del 1982. Alessandro Altobelli, Spillo, subentrato in finale e capace di segnare, diventando parte del mito. Quegli eroi — le loro storie, i loro gol, le loro celebrazioni — accompagnavano l’estate, alimentavano il plauso nazionale, riempivano le strade di bandiere tricolore. In quella stagione, il calcio diventava qualcosa che andava oltre lo sport: diventava simbolo, identità, speranza collettiva.
C’era una tensione collettiva e personale. Tutti sembravano aspettare qualcosa. Alcuni aspettavano il risultato della maturità, altri una risposta d’amore, altri ancora — come me — cercavano un varco verso il futuro. Pisa era la mia porta. E l’aria bollente di quella lunga estate mi spingeva a varcarla.
Mi preparai con metodo, quasi ossessivamente. Chimica, elettronica, matematica, fisica atomica… passai interi pomeriggi con le cuffie nelle orecchie e i manuali aperti davanti, alternando Pink Floyd e tabelle di reazioni. Sentivo che ce la potevo fare. Avevo voglia, metodo, passione. Ma non bastò. Durante l’orale, una domanda mi colse alla sprovvista: “Descriva a livello atomico cosa succede quando una nube di elio incontra una di azoto.” Rimasi senza parole. Una domanda secca, precisa, ma fuori dalle tracce. Mi sembra di ricordare che nessuno fu ritenuto all’altezza per la classe di scienze. Per me fu una piccola ferita, un esame non solo accademico ma anche personale. Ma fu anche una svolta.
Nonostante tutto, Pisa mi accolse con la sua atmosfera sospesa tra pietra e pensiero. Cominciai a scoprire la città, a viverla, a farne parte. La scelta della facoltà non fu immediata: ero diviso tra Ingegneria, più consolidata, e Informatica, una disciplina nuova, ancora giovane ma già affascinante. Scelsi Informatica. Mi sembrava il luogo giusto per coltivare il mio interesse per la logica, i sistemi e, forse inconsciamente, anche per l’intelligenza artificiale.
Goliardi, mantelli e vinili
La città era viva, piena di studenti, duemila iscritti al primo anno di Scienze dell’Informazione, di bici cigolanti, di notti che iniziavano tardi e finivano quando il sole era già alto. Conobbi Vittorio, Gianluca, Federica, Andrea, Attilio, e altri ancora. Ognuno di loro rappresentava un tassello diverso di quel mosaico che stava diventando la mia nuova vita.
Con Andrea condividevo l’amore per l’elettronica: passavamo serate a saldare, sperimentare, costruire piccoli strumenti che spesso funzionavano, ma a volte fumavano. Con Attilio, invece, mi addentrai in esperimenti meno ortodossi, spesso borderline, sempre creativi.
Fu con Vittorio e Gianluca che entrai nel mondo della goliardia pisana. Una tradizione fatta di scherzo, teatro, cultura classica, vino e improvvisazione. Girammo per la città in feluca e mantello, cantando in latino, discutendo di filosofia come se fossimo ancora in un’accademia del Cinquecento. Pisa era il nostro palcoscenico.
Già da tempo ero disk-jockey e organizzavo feste universitarie. Avevo una piccola attrezzatura, dischi selezionati con cura, e una naturale propensione a creare atmosfera. Ma fu con i goliardi che raggiungemmo l’apice: alla Sapienza organizzammo una festa destinata a diventare leggenda. Dovevano esserci cento persone. Ne arrivarono quasi tremila. Una bolgia, un inno alla gioventù, alla libertà, all’improvvisazione.
E quando volevamo staccare, ci rifugiavamo alla Casina Rossa a Lucca, un luogo che era insieme ritiro e palcoscenico, confine tra la goliardia e la contemplazione. Lì si parlava di tutto: arte, politica, amore, elettronica, cinema, filosofia, UNIX…
In facoltà: terminali, codici e sogni
Nel frattempo, in facoltà, scoprivo un altro mondo. Un mondo fatto di caratteri bianchi su fondo nero, di shell, di comandi misteriosi che sembravano formule magiche. Fu lì che vidi per la prima volta un sistema Unix vero. Il Berkeley 4.2, per la precisione.
Quel sistema arrivava da Amsterdam a Viareggio via UUCP, grazie a una piccola azienda pionieristica chiamata Delphi, con sede in via della Vetraia. Importavano sistemi HP, Apollo, SGI, Sun, e li distribuivano in tutta Italia. Quelle macchine erano potenti, costose, ma meravigliosamente aperte e spesso diventavano con Lisp e Prolog dei veri e propri Sistemi Esperti.
In facoltà, i più fortunati avevano un Macintosh SE come terminale grafico. Gli altri si arrangiavano con un VT100, austero, monocromatico, rumoroso. Ma nessuno si lamentava. Anzi. Quelle tastiere, quei monitor verdi, erano finestre sul futuro. Ogni script era un’avventura, ogni compilazione un piccolo successo. Successiamente, contribuii alla fondazione di i2u, la prima associazione italiana di utenti Unix ma anche alla nascita di associazioni come Assinform, AICA, Uniforum, …
Era un luogo di scambio, d’incontro, di crescita; ci si passava codice, manuali, bug da decifrare, script da perfezionare. In un’epoca senza internet, era già una rete. Di persone, di idee, di orizzonti.
Cinema, realtà e codice
E mentre esploravamo sistemi e linguaggi, fuori dalle aule il mondo raccontava le stesse cose con altri strumenti. Il cinema, ad esempio. Blade Runner ci interrogava su cosa volesse dire essere umani. Wargames ci mostrava come un ragazzo con un modem potesse quasi scatenare una guerra. Tron trasformava il codice in paesaggio.
Erano più che film. Erano specchi. Parlavano di noi, delle nostre paure, delle nostre ambizioni. Della tensione tra uomo e macchina, tra controllo e libertà, tra identità e simulazione.
E così, tra una serata alla Casina Rossa, una shell bash e una festa goliardica, io cambiavo. Senza accorgermene, stavo costruendo un’identità nuova. Non più solo studente, non ancora professionista. Ma esploratore. Di mondi, linguaggi, idee.
Dal piccolo studio radiofonico nascosto tra le colline, con le sue onde FM e i suoi trasmettitori improvvisati, ero arrivato in una città dove si trasmettevano idee, codice, connessioni. Se nel primo capitolo l’etere era il mio campo da gioco, qui era il protocollo. Ma lo spirito era lo stesso: usare la tecnologia per unire. Per parlare. Per non sentirsi soli.
Pisa fu tutto questo e molto di più. Era delusione, festa, terminali, amici, goliardia, rigore accademico e notti infinite, il luogo in cui cominciai a capire che la tecnologia non è mai solo tecnica. È linguaggio, relazione, immaginazione.
Il viaggio era cominciato. E non avrei più smesso di camminare.
Già allora intuivo che Unix non era solo un sistema operativo. Era parte di una cultura più grande, figlia dello spirito di Woodstock, del Sessantotto, della controcultura, dell’idea che la tecnologia potesse essere liberazione e non controllo. Quelle radici, cresciute tra Berkeley e la California ribelle, arrivavano fino a Pisa. E più avanti, proprio in California, ci sarei finito davvero. Ma questa, ancora, è un’altra tappa.