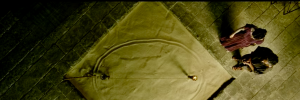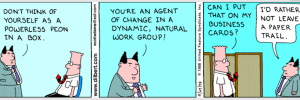Gli anni tra il 1982 e il 1988, prima della laurea, furono per me un periodo di straordinario fermento. Pisa, con i suoi laboratori universitari, era diventata una seconda casa: un luogo di studio, certo, ma anche di sperimentazione, di incontri e di prime esperienze professionali. Fu lì che iniziai a lavorare ai programmi europei Eureka ed Esprit, progetti che aprivano collaborazioni fra università e industria su tecnologie che allora avevano il sapore del futuro.
Non si trattava solo di teoria: erano lavori veri, con partner internazionali e scadenze precise. Per un giovane studente era un’occasione unica: trovarsi immerso in un contesto che univa ricerca e industria, e che guardava oltre i confini italiani. Persino la Russia era parte di quelle reti di collaborazione: i tecnici di Mosca sedevano allo stesso tavolo dei ricercatori californiani, e questa strana alchimia della Guerra Fredda si traduceva in un entusiasmo condiviso, che superava per qualche istante i blocchi ideologici. Il Muro di Berlino era ancora lì, simbolo di una divisione che sembrava eterna: sarebbe caduto solo il 9 novembre 1989, ma nei corridoi dei laboratori pisani si respirava già un’aria di apertura e di dialogo che lo superava in anticipo.
Anche le lingue dei manuali riflettevano quell’apertura. Tutti i testi di riferimento erano in inglese: protocolli, documentazioni tecniche, articoli di ricerca. L’unica eccezione erano gli standard del CCITT, l’organismo internazionale per le telecomunicazioni, che arrivavano in francese, costringendoci a un ulteriore esercizio linguistico. Era un continuo allenamento alla traduzione e all’adattamento: imparare l’informatica significava anche imparare a pensare in più lingue.
Le parole chiave che animavano le giornate erano quelle che avrebbero plasmato le decadi successive: sistemi aperti, workstation, intelligenza artificiale, stack TCP/IP, protocolli ISO. Oggi suonano come tecnologie consolidate, ma allora erano sfide pionieristiche. Nei laboratori imparavo a confrontarmi con la complessità, a scrivere righe di codice che non erano più un esercizio accademico, ma parte di architetture che prefiguravano il mondo digitale in cui viviamo oggi.
Eppure non era tutto rigore. Ricordo i pomeriggi passati a giocare a Rogue sui sistemi Unix: dungeon fatti di caratteri ASCII che ci assorbivano come veri mondi paralleli. Bastavano simboli e lettere per immaginare spade, mostri, stanze segrete. Tra una funzione di rete e una simulazione, ci prendevamo il lusso di un’avventura virtuale. Era il lato ludico della stessa tecnologia che, poche ore prima, studiavamo con serietà.
Il contesto storico faceva da cornice e amplificava quella sensazione di vivere un’epoca di passaggio. Le radio trasmettevano “Every Breath You Take” dei Police, “Take On Me” degli A-ha, e in Italia si ballava con Vasco Rossi e Claudio Baglioni. Al cinema scorrevano i titoli di film che sarebbero diventati cult: Amadeus (1984), Top Gun (1986). C’era un’atmosfera sospesa tra distopia e leggerezza, tra ansia per il futuro e voglia di libertà.
Il CNUCE era un crocevia di energie nuove. IBM e Olivetti portavano a Pisa investimenti e visioni industriali; i professori aprivano strade allora impensabili; i ricercatori più anziani condividevano entusiasmi e fatiche. Camminando lungo l’Arno, tra la Sapienza e i laboratori, sentivo chiaramente che lì si stava giocando una partita che non era solo accademica, ma anche culturale e sociale.
Pisa fu davvero il mio trampolino: una città che, tra un caffè in piazza dei Cavalieri, le notti passate a leggere manuali in inglese o in francese, i pomeriggi persi a decifrare bug nei sistemi e le ore a combattere mostri virtuali in Rogue, mi mostrava che la tecnologia poteva essere ricerca, lavoro e gioco insieme. Fu lì che capii che la mia strada sarebbe stata intrecciata con l’innovazione, e che quel periodo di apprendistato sarebbe rimasto inciso nella memoria come una delle stagioni più fertili e formative della mia vita.
Il periodo pisano, tra progetti europei, esperimenti nei laboratori e pomeriggi passati davanti a un terminal Unix, sembrava avermi aperto le porte del futuro. Mi muovevo già tra codici e protocolli, tra i primi contatti con aziende e ricercatori, convinto che il passo successivo sarebbe stato naturale: terminare l’università ed entrare, finalmente, nel mondo del lavoro.
Ma la storia aveva altri piani.